




 Copyright Renato Riva 2010
E' un romanzo di montagna ambientato su una parete della splendida
Valle di Rhemes, la Est della Grande Rousse, alta 1000 metri, da 2600
a 3600, verticale, pericolosa e lunga. Mai salita.
La vicenda si svolge negli anni settanta e ha per protagonisti dei
ragazzi di Milano (in quegli anni Milano 'produceva' i Guerini e i
Dinoia...) i quali si innamorano della valle, cominciano a praticare
l'alpinismo in Grigna, Masino e Monte Bianco fino ad arrivare ad alto
livello e poi si ossessionano a voler salire quella parete.
Ho scritto questo libro per cercare di spiegare come sia la passione a
portare a volte le persone oltre la soglia del rischio, e non
l'impreparazione o l'improvvisazione. Se notate, ogni volta che avviene
una disgrazia in montagna ci sono sempre alpinisti che spiegano che e'
stato fatto qualche imperdonabile errore. Invece io penso che non sia
cosi' e che quando muore un velista, ad esempio, il mondo della vela
fa quadrato attorno a lui, mentre quando muore un alpinista il mondo
della montagna (in molti, troppi casi) lo mette alla berlina. Chi non ha
mai fatto errori in montagna scagli la prima pietra.
Ho dedicato il libro a quattro ragazzi piemontesi morti quest'inverno
sulla Nord dell'Aiguille du Midi. Non li conoscevo. Ma il giorno dopo la
loro morte il Corriere della Sera scriveva: 'Cosi' il Monte Bianco e'
diventato un Luna Park', sottotitolo: Rischi e improvvisazione. E cosi'
alcuni altri quotidiani, mentre Messner spiegava che andare di conserva
in montagna e' un grave errore. Io la penso diversamente e ho messo il
mio sentire nel libro
Copyright Renato Riva 2010
E' un romanzo di montagna ambientato su una parete della splendida
Valle di Rhemes, la Est della Grande Rousse, alta 1000 metri, da 2600
a 3600, verticale, pericolosa e lunga. Mai salita.
La vicenda si svolge negli anni settanta e ha per protagonisti dei
ragazzi di Milano (in quegli anni Milano 'produceva' i Guerini e i
Dinoia...) i quali si innamorano della valle, cominciano a praticare
l'alpinismo in Grigna, Masino e Monte Bianco fino ad arrivare ad alto
livello e poi si ossessionano a voler salire quella parete.
Ho scritto questo libro per cercare di spiegare come sia la passione a
portare a volte le persone oltre la soglia del rischio, e non
l'impreparazione o l'improvvisazione. Se notate, ogni volta che avviene
una disgrazia in montagna ci sono sempre alpinisti che spiegano che e'
stato fatto qualche imperdonabile errore. Invece io penso che non sia
cosi' e che quando muore un velista, ad esempio, il mondo della vela
fa quadrato attorno a lui, mentre quando muore un alpinista il mondo
della montagna (in molti, troppi casi) lo mette alla berlina. Chi non ha
mai fatto errori in montagna scagli la prima pietra.
Ho dedicato il libro a quattro ragazzi piemontesi morti quest'inverno
sulla Nord dell'Aiguille du Midi. Non li conoscevo. Ma il giorno dopo la
loro morte il Corriere della Sera scriveva: 'Cosi' il Monte Bianco e'
diventato un Luna Park', sottotitolo: Rischi e improvvisazione. E cosi'
alcuni altri quotidiani, mentre Messner spiegava che andare di conserva
in montagna e' un grave errore. Io la penso diversamente e ho messo il
mio sentire nel libro
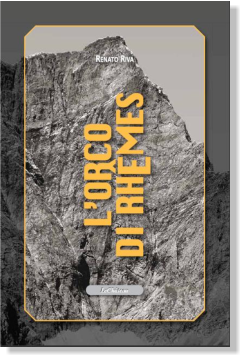



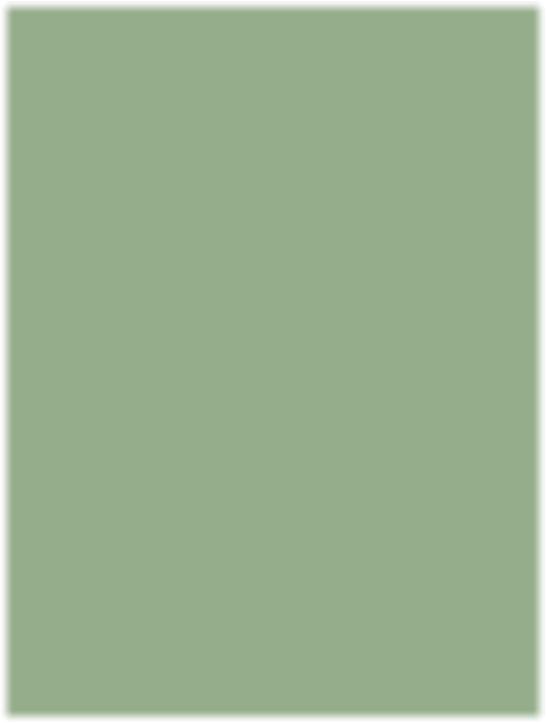 Gli ultimi raggi del sole al tramonto scavalcano i fianchi delle montagne e si
proiettano verso le cime che chiudono la valle di Rhemes. E’ una sera di settembre,
calda e gradevole anche ai 1900 metri di Thumel, quattro baite conficcate in fondo alla
valle ancora selvaggia. La Dora scorre, riposante a vedersi, sul grande piano
alluvionale dove i salici contendono ai larici le labili sponde del fiume e il rumore delle
sue acque vigorose, rimbalzato da infinite quinte di roccia e amplificato nei profondi
valloni, risuona poderoso ovunque. Tutto e’ fermo e quasi incantato in un fine estate
che manda ancora qualche folata di calura su per la valle.
(..........)
E’ una valle rara, quella di Rhemes, per le Alpi italiane. Scorre all’inverso, da Nord
verso Sud ed e’ dritta come un fuso, senza svolte ne’ tornanti. Assomiglia piu’ alle valli
svizzere del Vallese, sul versante Nord delle Alpi, che a quelle tipiche del nostro fianco
meridionale.
E appunto, verso Nord, l’enorme mole del Gran Combin si erge, come un antico velo
del tempio, a sbarrare la stretta uscita della lunga valle e a completare un quadro in
cui nevi e ghiacci non danno tregua all’occhio del visitatore.
Piccoli gruppi di alpinisti divallano, camminando rilassati lungo il sentiero che
scende dal rifugio, il Benevolo, e parlottando tra loro del piu’ e del meno. Forse
raccontandosi storie di avventure vissute nell’aria sottile di quella e di tante altre valli
che li hanno attirati verso l’alto, verso le nuvole o verso le stelle. E cosi’ camminando,
a volte a gruppetti e a volte in fila indiana, obbedendo al dettato del sentiero, ora largo
e ora stretto, si lasciano alle spalle i grandi pendii prativi che sostengono i castelli di
rocce della Gran Vaudala, alla loro destra, e della regione del Bassac, a sinistra. Poi,
attraversata la forra di Fos, selvaggia e intimidatoria, il sentiero li accompagna vicino
al bordo sinistro di un canion profondo, dentro il quale la Dora si costringe . La valle,
che sin li’ e’ stata ampia e spaziosa e che li ha abbracciati nei suoi mantelli bianchi in
alto e verdi piu’ in basso, adesso li obbliga tra una ripida parete, a sinistra, e il baratro
del fiume, a destra. Da questa morsa liberandoli solo al sopraggiungere della piana di
Thumel, non un metro prima.
Li’, nel punto in cui l’orizzonte si allunga verso Nord per lasciar loro vedere di nuovo i
ghiacci del Grand Combin, si apre improvvisamente sulla sinistra un antro immenso
che nulla ha a che spartire con la dolcezza di cio’ che si lasciano alle spalle. Alto 1800
metri e largo almeno due chilometri, l’arcigno fianco Est della Grande Rousse rapisce
per un attimo i loro sguardi e interrompe il loro conversare. Molti, fermandosi un
istante, lo indicano, con gesti o semplicemente con un cenno del capo, forse
commentando quanto rude quella vista sia o quanto slanciata e aerea la cresta che la
chiude a settentrione appaia. Oppure commentando gli enormi imbuti di roccia che
racchiude o i lunghi canaloni verticali che lo solcano. O, infine, notando in una valle
tanto ricca di camosci e stambecchi, la totale loro assenza dai pascoli che ne stanno
alla base. E l’assenza di sentieri, segno che i montanari, nei secoli, se ne sono sempre
tenuti a distanza.
Nessuno di loro immaginerebbe mai, in questa calma dolce di fine domenica, che
l’immenso mare di roccia tenga prigioniera una vita, un essere, un naufrago.
Qualcuno che ha evidentemente osato sfidarlo e violarlo fino a raggiungere , quasi, la
sua imponente vetta.
Eppure e’ cosi’.
Gli ultimi raggi del sole al tramonto scavalcano i fianchi delle montagne e si
proiettano verso le cime che chiudono la valle di Rhemes. E’ una sera di settembre,
calda e gradevole anche ai 1900 metri di Thumel, quattro baite conficcate in fondo alla
valle ancora selvaggia. La Dora scorre, riposante a vedersi, sul grande piano
alluvionale dove i salici contendono ai larici le labili sponde del fiume e il rumore delle
sue acque vigorose, rimbalzato da infinite quinte di roccia e amplificato nei profondi
valloni, risuona poderoso ovunque. Tutto e’ fermo e quasi incantato in un fine estate
che manda ancora qualche folata di calura su per la valle.
(..........)
E’ una valle rara, quella di Rhemes, per le Alpi italiane. Scorre all’inverso, da Nord
verso Sud ed e’ dritta come un fuso, senza svolte ne’ tornanti. Assomiglia piu’ alle valli
svizzere del Vallese, sul versante Nord delle Alpi, che a quelle tipiche del nostro fianco
meridionale.
E appunto, verso Nord, l’enorme mole del Gran Combin si erge, come un antico velo
del tempio, a sbarrare la stretta uscita della lunga valle e a completare un quadro in
cui nevi e ghiacci non danno tregua all’occhio del visitatore.
Piccoli gruppi di alpinisti divallano, camminando rilassati lungo il sentiero che
scende dal rifugio, il Benevolo, e parlottando tra loro del piu’ e del meno. Forse
raccontandosi storie di avventure vissute nell’aria sottile di quella e di tante altre valli
che li hanno attirati verso l’alto, verso le nuvole o verso le stelle. E cosi’ camminando,
a volte a gruppetti e a volte in fila indiana, obbedendo al dettato del sentiero, ora largo
e ora stretto, si lasciano alle spalle i grandi pendii prativi che sostengono i castelli di
rocce della Gran Vaudala, alla loro destra, e della regione del Bassac, a sinistra. Poi,
attraversata la forra di Fos, selvaggia e intimidatoria, il sentiero li accompagna vicino
al bordo sinistro di un canion profondo, dentro il quale la Dora si costringe . La valle,
che sin li’ e’ stata ampia e spaziosa e che li ha abbracciati nei suoi mantelli bianchi in
alto e verdi piu’ in basso, adesso li obbliga tra una ripida parete, a sinistra, e il baratro
del fiume, a destra. Da questa morsa liberandoli solo al sopraggiungere della piana di
Thumel, non un metro prima.
Li’, nel punto in cui l’orizzonte si allunga verso Nord per lasciar loro vedere di nuovo i
ghiacci del Grand Combin, si apre improvvisamente sulla sinistra un antro immenso
che nulla ha a che spartire con la dolcezza di cio’ che si lasciano alle spalle. Alto 1800
metri e largo almeno due chilometri, l’arcigno fianco Est della Grande Rousse rapisce
per un attimo i loro sguardi e interrompe il loro conversare. Molti, fermandosi un
istante, lo indicano, con gesti o semplicemente con un cenno del capo, forse
commentando quanto rude quella vista sia o quanto slanciata e aerea la cresta che la
chiude a settentrione appaia. Oppure commentando gli enormi imbuti di roccia che
racchiude o i lunghi canaloni verticali che lo solcano. O, infine, notando in una valle
tanto ricca di camosci e stambecchi, la totale loro assenza dai pascoli che ne stanno
alla base. E l’assenza di sentieri, segno che i montanari, nei secoli, se ne sono sempre
tenuti a distanza.
Nessuno di loro immaginerebbe mai, in questa calma dolce di fine domenica, che
l’immenso mare di roccia tenga prigioniera una vita, un essere, un naufrago.
Qualcuno che ha evidentemente osato sfidarlo e violarlo fino a raggiungere , quasi, la
sua imponente vetta.
Eppure e’ cosi’.





 Copyright Renato Riva 2010
E' un romanzo di montagna ambientato su una parete della splendida
Valle di Rhemes, la Est della Grande Rousse, alta 1000 metri, da 2600
a 3600, verticale, pericolosa e lunga. Mai salita.
La vicenda si svolge negli anni settanta e ha per protagonisti dei
ragazzi di Milano (in quegli anni Milano 'produceva' i Guerini e i
Dinoia...) i quali si innamorano della valle, cominciano a praticare
l'alpinismo in Grigna, Masino e Monte Bianco fino ad arrivare ad alto
livello e poi si ossessionano a voler salire quella parete.
Ho scritto questo libro per cercare di spiegare come sia la passione a
portare a volte le persone oltre la soglia del rischio, e non
l'impreparazione o l'improvvisazione. Se notate, ogni volta che avviene
una disgrazia in montagna ci sono sempre alpinisti che spiegano che e'
stato fatto qualche imperdonabile errore. Invece io penso che non sia
cosi' e che quando muore un velista, ad esempio, il mondo della vela
fa quadrato attorno a lui, mentre quando muore un alpinista il mondo
della montagna (in molti, troppi casi) lo mette alla berlina. Chi non ha
mai fatto errori in montagna scagli la prima pietra.
Ho dedicato il libro a quattro ragazzi piemontesi morti quest'inverno
sulla Nord dell'Aiguille du Midi. Non li conoscevo. Ma il giorno dopo la
loro morte il Corriere della Sera scriveva: 'Cosi' il Monte Bianco e'
diventato un Luna Park', sottotitolo: Rischi e improvvisazione. E cosi'
alcuni altri quotidiani, mentre Messner spiegava che andare di conserva
in montagna e' un grave errore. Io la penso diversamente e ho messo il
mio sentire nel libro
Copyright Renato Riva 2010
E' un romanzo di montagna ambientato su una parete della splendida
Valle di Rhemes, la Est della Grande Rousse, alta 1000 metri, da 2600
a 3600, verticale, pericolosa e lunga. Mai salita.
La vicenda si svolge negli anni settanta e ha per protagonisti dei
ragazzi di Milano (in quegli anni Milano 'produceva' i Guerini e i
Dinoia...) i quali si innamorano della valle, cominciano a praticare
l'alpinismo in Grigna, Masino e Monte Bianco fino ad arrivare ad alto
livello e poi si ossessionano a voler salire quella parete.
Ho scritto questo libro per cercare di spiegare come sia la passione a
portare a volte le persone oltre la soglia del rischio, e non
l'impreparazione o l'improvvisazione. Se notate, ogni volta che avviene
una disgrazia in montagna ci sono sempre alpinisti che spiegano che e'
stato fatto qualche imperdonabile errore. Invece io penso che non sia
cosi' e che quando muore un velista, ad esempio, il mondo della vela
fa quadrato attorno a lui, mentre quando muore un alpinista il mondo
della montagna (in molti, troppi casi) lo mette alla berlina. Chi non ha
mai fatto errori in montagna scagli la prima pietra.
Ho dedicato il libro a quattro ragazzi piemontesi morti quest'inverno
sulla Nord dell'Aiguille du Midi. Non li conoscevo. Ma il giorno dopo la
loro morte il Corriere della Sera scriveva: 'Cosi' il Monte Bianco e'
diventato un Luna Park', sottotitolo: Rischi e improvvisazione. E cosi'
alcuni altri quotidiani, mentre Messner spiegava che andare di conserva
in montagna e' un grave errore. Io la penso diversamente e ho messo il
mio sentire nel libro
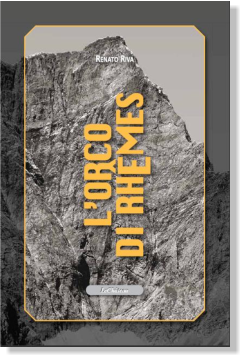



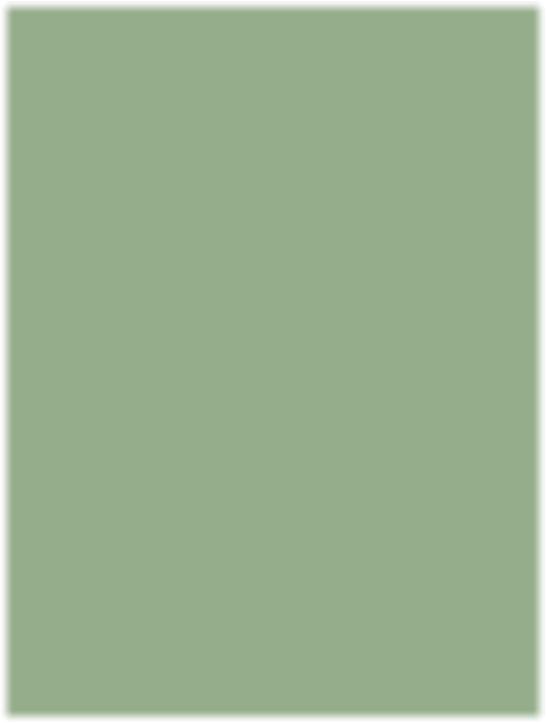 Gli ultimi raggi del sole al tramonto scavalcano i fianchi delle montagne e si
proiettano verso le cime che chiudono la valle di Rhemes. E’ una sera di settembre,
calda e gradevole anche ai 1900 metri di Thumel, quattro baite conficcate in fondo alla
valle ancora selvaggia. La Dora scorre, riposante a vedersi, sul grande piano
alluvionale dove i salici contendono ai larici le labili sponde del fiume e il rumore delle
sue acque vigorose, rimbalzato da infinite quinte di roccia e amplificato nei profondi
valloni, risuona poderoso ovunque. Tutto e’ fermo e quasi incantato in un fine estate
che manda ancora qualche folata di calura su per la valle.
(..........)
E’ una valle rara, quella di Rhemes, per le Alpi italiane. Scorre all’inverso, da Nord
verso Sud ed e’ dritta come un fuso, senza svolte ne’ tornanti. Assomiglia piu’ alle valli
svizzere del Vallese, sul versante Nord delle Alpi, che a quelle tipiche del nostro fianco
meridionale.
E appunto, verso Nord, l’enorme mole del Gran Combin si erge, come un antico velo
del tempio, a sbarrare la stretta uscita della lunga valle e a completare un quadro in
cui nevi e ghiacci non danno tregua all’occhio del visitatore.
Piccoli gruppi di alpinisti divallano, camminando rilassati lungo il sentiero che
scende dal rifugio, il Benevolo, e parlottando tra loro del piu’ e del meno. Forse
raccontandosi storie di avventure vissute nell’aria sottile di quella e di tante altre valli
che li hanno attirati verso l’alto, verso le nuvole o verso le stelle. E cosi’ camminando,
a volte a gruppetti e a volte in fila indiana, obbedendo al dettato del sentiero, ora largo
e ora stretto, si lasciano alle spalle i grandi pendii prativi che sostengono i castelli di
rocce della Gran Vaudala, alla loro destra, e della regione del Bassac, a sinistra. Poi,
attraversata la forra di Fos, selvaggia e intimidatoria, il sentiero li accompagna vicino
al bordo sinistro di un canion profondo, dentro il quale la Dora si costringe . La valle,
che sin li’ e’ stata ampia e spaziosa e che li ha abbracciati nei suoi mantelli bianchi in
alto e verdi piu’ in basso, adesso li obbliga tra una ripida parete, a sinistra, e il baratro
del fiume, a destra. Da questa morsa liberandoli solo al sopraggiungere della piana di
Thumel, non un metro prima.
Li’, nel punto in cui l’orizzonte si allunga verso Nord per lasciar loro vedere di nuovo i
ghiacci del Grand Combin, si apre improvvisamente sulla sinistra un antro immenso
che nulla ha a che spartire con la dolcezza di cio’ che si lasciano alle spalle. Alto 1800
metri e largo almeno due chilometri, l’arcigno fianco Est della Grande Rousse rapisce
per un attimo i loro sguardi e interrompe il loro conversare. Molti, fermandosi un
istante, lo indicano, con gesti o semplicemente con un cenno del capo, forse
commentando quanto rude quella vista sia o quanto slanciata e aerea la cresta che la
chiude a settentrione appaia. Oppure commentando gli enormi imbuti di roccia che
racchiude o i lunghi canaloni verticali che lo solcano. O, infine, notando in una valle
tanto ricca di camosci e stambecchi, la totale loro assenza dai pascoli che ne stanno
alla base. E l’assenza di sentieri, segno che i montanari, nei secoli, se ne sono sempre
tenuti a distanza.
Nessuno di loro immaginerebbe mai, in questa calma dolce di fine domenica, che
l’immenso mare di roccia tenga prigioniera una vita, un essere, un naufrago.
Qualcuno che ha evidentemente osato sfidarlo e violarlo fino a raggiungere , quasi, la
sua imponente vetta.
Eppure e’ cosi’.
Gli ultimi raggi del sole al tramonto scavalcano i fianchi delle montagne e si
proiettano verso le cime che chiudono la valle di Rhemes. E’ una sera di settembre,
calda e gradevole anche ai 1900 metri di Thumel, quattro baite conficcate in fondo alla
valle ancora selvaggia. La Dora scorre, riposante a vedersi, sul grande piano
alluvionale dove i salici contendono ai larici le labili sponde del fiume e il rumore delle
sue acque vigorose, rimbalzato da infinite quinte di roccia e amplificato nei profondi
valloni, risuona poderoso ovunque. Tutto e’ fermo e quasi incantato in un fine estate
che manda ancora qualche folata di calura su per la valle.
(..........)
E’ una valle rara, quella di Rhemes, per le Alpi italiane. Scorre all’inverso, da Nord
verso Sud ed e’ dritta come un fuso, senza svolte ne’ tornanti. Assomiglia piu’ alle valli
svizzere del Vallese, sul versante Nord delle Alpi, che a quelle tipiche del nostro fianco
meridionale.
E appunto, verso Nord, l’enorme mole del Gran Combin si erge, come un antico velo
del tempio, a sbarrare la stretta uscita della lunga valle e a completare un quadro in
cui nevi e ghiacci non danno tregua all’occhio del visitatore.
Piccoli gruppi di alpinisti divallano, camminando rilassati lungo il sentiero che
scende dal rifugio, il Benevolo, e parlottando tra loro del piu’ e del meno. Forse
raccontandosi storie di avventure vissute nell’aria sottile di quella e di tante altre valli
che li hanno attirati verso l’alto, verso le nuvole o verso le stelle. E cosi’ camminando,
a volte a gruppetti e a volte in fila indiana, obbedendo al dettato del sentiero, ora largo
e ora stretto, si lasciano alle spalle i grandi pendii prativi che sostengono i castelli di
rocce della Gran Vaudala, alla loro destra, e della regione del Bassac, a sinistra. Poi,
attraversata la forra di Fos, selvaggia e intimidatoria, il sentiero li accompagna vicino
al bordo sinistro di un canion profondo, dentro il quale la Dora si costringe . La valle,
che sin li’ e’ stata ampia e spaziosa e che li ha abbracciati nei suoi mantelli bianchi in
alto e verdi piu’ in basso, adesso li obbliga tra una ripida parete, a sinistra, e il baratro
del fiume, a destra. Da questa morsa liberandoli solo al sopraggiungere della piana di
Thumel, non un metro prima.
Li’, nel punto in cui l’orizzonte si allunga verso Nord per lasciar loro vedere di nuovo i
ghiacci del Grand Combin, si apre improvvisamente sulla sinistra un antro immenso
che nulla ha a che spartire con la dolcezza di cio’ che si lasciano alle spalle. Alto 1800
metri e largo almeno due chilometri, l’arcigno fianco Est della Grande Rousse rapisce
per un attimo i loro sguardi e interrompe il loro conversare. Molti, fermandosi un
istante, lo indicano, con gesti o semplicemente con un cenno del capo, forse
commentando quanto rude quella vista sia o quanto slanciata e aerea la cresta che la
chiude a settentrione appaia. Oppure commentando gli enormi imbuti di roccia che
racchiude o i lunghi canaloni verticali che lo solcano. O, infine, notando in una valle
tanto ricca di camosci e stambecchi, la totale loro assenza dai pascoli che ne stanno
alla base. E l’assenza di sentieri, segno che i montanari, nei secoli, se ne sono sempre
tenuti a distanza.
Nessuno di loro immaginerebbe mai, in questa calma dolce di fine domenica, che
l’immenso mare di roccia tenga prigioniera una vita, un essere, un naufrago.
Qualcuno che ha evidentemente osato sfidarlo e violarlo fino a raggiungere , quasi, la
sua imponente vetta.
Eppure e’ cosi’.


